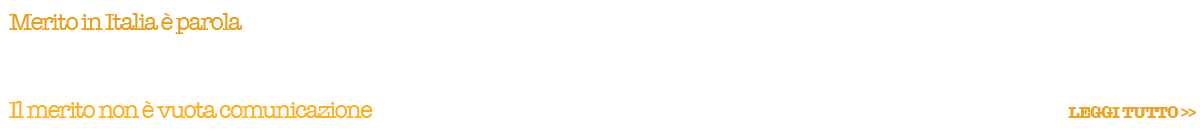“Capitalismo socialista”: l’ossimoro della Sharing Economy (di Francesco Laschi)
“I nostri figli guideranno veicoli silenziosi, puliti e intelligenti, integrati in una rete interattiva piatta, distribuita e collaborativa. Anche solo questo è un segno della fine di un’era economica e dell’inizio di un’altra” (Jeremy Rifkin).
Le parole del noto economista americano affidano un ruolo centrale al concetto di collaborazione, ritenuta cruciale nella nuova e nascente economia mondiale. Più volte Rifkin ha ribadito come la cosiddetta sharing economy, l’economia della condivisione, stia sostituendo i due maggiori sistemi economici del novecento: socialismo e capitalismo. Anche se, a ben vedere, “sostituire” forse non è proprio la parola più adatta, dal momento che, se analizzata, la nuova economia costituisce un modello ibrido che si pone in mezzo ai due “vecchi” mondi: da una parte logiche di mercato e commerciali spinte, profondamente ispirate dal sistema capitalistico; dall’altra una rete collaborativa, basata sulla condivisione di beni e servizi. Di certo, tenuto conto di vari campanelli d’allarme (calo dei PIL dei paesi economicamente forti, disoccupazione crescente, compressione delle quote di mercato e crescita stagnante), le “risorse” della “Seconda Rivoluzione Industriale”, quali centralità delle economie legate al petrolio, all’industria e non più all’agricoltura e all’estensione dei centri urbani, stanno viaggiando verso l’esaurimento e, dopo una fase di maturità, l’economia ad esse collegata sembra avviarsi verso una parabola discendente. In tal senso, la progressiva e rapida crescita dei settori di “condivisione” a discapito di quelli tradizionali è ben descritta ad esempio nel lavoro di PWC http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html, dove si parla di un giro di affari complessivo di 335 miliardi di dollari entro il 2025, quando – si prevede – verranno raggiunti i guadagni dei settori tradizionali. I ritmi di sviluppo, del resto, appaiono davvero vertiginosi, in alcuni casi superiori del 1000 %.
Ma proviamo a definire i veri punti di forza della nuova economia della condivisione. Prenderei le mosse da una definizione, quella contenuta nella proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 2016, riguardante appunto la sharing economy (“Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione”): “l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese”.
Due figure principali, i gestori e gli utenti. I primi che mettono in contatto gli utenti,; i secondi che, invece, mettono a disposizione il bene o servizio attraverso la piattaforma. Ciò premesso, vorrei analizzare i punti di forza di tale approccio economico, partendo “dalla superficie”. Ebbene, le aziende operanti nella sharing economy si basano su un sistema di erogazione di servizi tramite piattaforme digitali strettamente legate a social network, ubique, e in continua connessione con l’utente. Si basano quindi su meccanismi semplici da capire e usare, in modo da accompagnare l’utente durante tutta l’esperienza di fruizione e facilitare l’acquisto. La facilità di acquisto e utilizzo è importante, poiché l’erogazione dei servizi a prezzi contenuti deve spingere il cliente verso reiterati acquisti e, nel migliore dei casi, alla fidelizzazione data da un utilizzo quotidiano. Essendo società digitali, il cliente (in un’ottica user-centric) è centrale nella definizione del prodotto. L’utente, difatti, si giova principalmente di un risparmio economico notevole rispetto ai servizi tradizionali; ad esempio, nei servizi di car sharing i prezzi applicati sono inferiori a quelli di un taxi, e il servizio offerto comprende benzina, parcheggi anche a pagamento, capillarità, ingressi in zone a traffico limitato. Bisogna poi pensare all’opportunità che un utilizzatore trae dal network, non solo per il bene che, tramite lo sharing, mette a reddito, ma anche dal punto di vista fiscale. Pensiamo al famoso caso di Airbnb, società che permette di condividere un alloggio con gli iscritti alla community; i Comuni hanno soltanto recentemente previsto la tassa di soggiorno per tali tipologie di affitto turistico e, in generale, il regime fiscale di queste attività non risulta ancora ben definito per mancanza di una normativa ad hoc (tali lacune però saranno presto colmate visto il clamore sorto intorno a tali mercati digitali; in tal senso vedasi anche la già citata proposta di legge “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione”[1]). La possibilità di proporre prezzi altamente competitivi deriva, in gran parte, dai costi marginali decisamente bassi delle sharing enterprises: costi strutturali, di rinnovamento locali o mezzi sono infatti scaricati in toto sull’utente che mette il bene a disposizione. Assai ridotti sono poi i costi organizzativi. Tutte le aziende dispongono di organizzazioni leggere, con organico inferiore a qualsiasi altro competitor: Blablacar ha 100 dipendenti (dato più recente al 2013), Airbnb 1600, Uber 3500, Robin Hood ha iniziato l’attività con 3 dipendenti. Ciò comporta di minori costi per personale, circolazione rapida delle informazioni interne, abbattimento dei “silos” aziendali e dei compartimenti stagni.
Si aggiunga la trasparenza. Un fattore non trascurabile: i prezzi di acquisto offerti dalle società dell’economia condivisa sono sempre piuttosto trasparenti, evidenziando con chiarezza commissioni, tasse, tariffe. Provate ad esempio a leggere una mail di ricevuta di Enjoy, la società di car sharing del gruppo ENI, oppure la ricevuta di una stanza affittata con Airbnb, certamente troverete ben distinti prezzo della camera, eventuali tasse (come IVA), commissioni per il servizio. Tali importi sono comunque chiari anche prima dell’acquisto e chiaro è, soprattutto, il prezzo finale del bene che andremo a noleggiare o affittare. La trasparenza, del resto, è oggi necessaria per le attività on line: essere trasparenti è la via da seguire per fidelizzare il cliente.
I motivi del successo della sharing economy appaiono, insomma, piuttosto chiari. Ma possiamo definirla una rivoluzione non solo in termini di business, ma anche culturale?
Bene ha detto Claudio Giunta, “un utente sicuro di sé e del suo mondo è l'ultima cosa che la macchina del consumo possa augurarsi”; ciò a riprova del fatto che il superamento degli stereotipi economici passa dalla crescita culturale dell’individuo, anzitutto, e dal mercato, poi. La sharing economy ha un bisogno vitale: alfabetizzare l’utente finale; quest’ultimo, per accedere ai vari servizi offerti, è infatti costretto a “digitalizzarsi” . Vi è poi il tema – centrale – del network collaborativo, cui si accennava all’inizio. Il network rappresenta difatti il valore economico fondamentale per la sharing economy. Avere una community ricca di utenti significa non solo avere molti clienti, ma anche avere a disposizione i dati riguardanti gli stessi. Lo studio e l’analisi dei big data è dunque il patrimonio più prezioso, vera e propria moneta di scambio, in quanto la gestione dei dati può portare un enorme vantaggio competitivo e ritorni economici cospicui, grazie alla predizione dei bisogni futuri fatta con estrema precisione rispetto al passato.
L’attenzione delle aziende ai dati che rendiamo disponibili in rete (non solo le informazioni personali, ma i nostri interessi, attività, preferenze ecc.) mira infine alla predisposizione di una sorta di “guida” per il consumatore finale che lo conduca all’acquisto dei propri prodotti. Il risultato è una “intermediazione” del mondo reale, dove l’esperienza diretta, i sensi, l’istinto e la ricerca quali-quantitativa della persona-consumatore sono condizionati da una digital map, una strada creata digitalmente per influenzare le scelte dell’user nel quotidiano.
Una delle più grandi sfide per la rivoluzione della condivisione sarà quindi quella di creare la capacità mentale di svincolarsi dai percorsi predisposti, attraverso nuove logiche e nuove interpretazioni, non solo del mercato, ma della realtà stessa. Difficile, se non impossibile, fare previsioni su questa vera e propria evoluzione delle forme del pensiero umano. Rimane però sempre valida la riflessione di Albert Einstein: “Il mondo che abbiamo creato è il prodotto del nostro pensiero e dunque non può cambiare se prima non modifichiamo il nostro modo di pensare”. Al centro – si spera e si crede – vi sarà sempre l’Uomo e il suo pensiero. Al centro di una “nuova intelligenza collettiva” per un mondo dove la condivisione, appunto, diviene economia.
30 gennaio 2017
[1] La disciplina fiscale è, in particolare, contenuta nell’art. 5. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato “reddito da attività di economia della condivisione non professionale” ed è indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10.000 euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10 per cento. I redditi superiori a 10.000 euro sono invece cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e ad essi si applica dunque l’aliquota corrispondente. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme digitali, in qualità di sostituti d’imposta degli utenti operatori. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all’estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia. Gli stessi gestori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall’attività svolta mediante le piattaforme medesime.