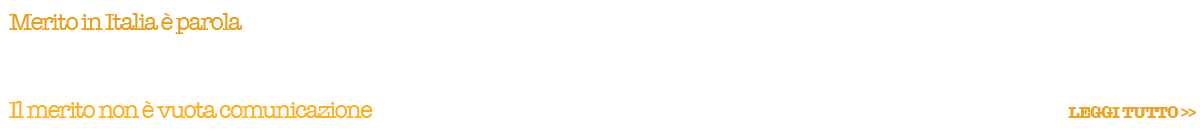La separazione tra banche d’affari e banche commerciali tra ipotesi nazionale e realtà delle scelte sovranazionali. (Parte Seconda) (di Michele Cossa)

Come visto nel primo intervento, la grave crisi finanziaria che a partire dal 2008 ha colpito, in pratica, l’intero sistema finanziario mondiale ha spinto ad un ripensamento delle politiche di sostanziale deregulation del settore finanziario, che, indulgendo ad un laissez-faire fondato su una generale fiducia sull’autodisciplina del mercato e dei suoi operatori, aveva finito anche per permettere l’adozione di comportamenti rischiosi, che avevano innescato, o concorso a propagare, gli effetti della congiuntura negativa.
L’esame in dettaglio delle singole iniziative legislative nazionali e sovranazionali volte a contenere gli effetti della crisi e, soprattutto, ad evitarne una ripetizione, è opera che ormai, a dieci anni di distanza, richiederebbe più che uno sforzo monografico, una vera e propria collana di scritti, tanto variegato e articolato appare il quadro.
Appare ai nostri fini più interessante, oltre che più realistico, soffermarsi sul dibattito che quasi istantaneamente è sorto in ordine alla necessità di rivedere il modello di banca universale e di individuare dei limiti alla possibilità per gli istituti che raccolgono fondi presso la generalità indistinta del pubblico di investire tali fondi in attività speculative ad alto rischio, finendo per metterne a repentaglio la restituzione[1].
Partendo dal Paese in cui la crisi era esplosa, gli Stati Uniti, fu proprio per rimarginare il vulnus alla fiducia dei risparmiatori che venne adottato nel 2010 il Dodd-Frank Act, un intervento di riforma estremamente elaborato e complesso, di cui qui va ricordata soprattutto la cd. Volcker Rule. Quest’ultima è la comune denominazione che viene conferita a quella parte della riforma, ideata appunto dall’ex Presidente della Federal Reserve, l’economista Paul Volcker, che recupera alcuni aspetti dello storico Glass-Steagall Act, imponendo un intervento di tipo strutturale sul mercato bancario. L’intento, in generale, era infatti quello di evitare che le banche che raccolgono depositi “protetti”, cioè soggetti alla tutela del sistema di garanzia dei depositi statunitense, svolgessero attività (speculativa) di trading proprietario e attività di investimento in fondi ad operatività particolarmente rischiosa (gli hedge funds, in particolare); e la Volcker Rule pone un esplicito divieto al riguardo.
Il ritorno al passato sembra quasi testuale; senonché, la (apparentemente) chiara previsione del §619 del Dodd-Frank Act è temperata, nella stessa parte dell’atto, da una serie di rilevanti precisazioni ed eccezioni. E, soprattutto, la regola presuppone esplicitamente un’attività regolamentare ed attuativa di tale vastità e complessità che sembra davvero difficile individuare in essa qualcosa di più di una, sia pure rilevante, enunciazione di principio, mentre il contenuto sostanziale-precettivo, ed in particolare il perimetro del divieto, è sostanzialmente rimesso all’apporto delle varie autorità di regolazione. La disciplina attuativa esiste, ed è di una mole tale da scoraggiare lo studioso che vi si accosti in assenza di necessità pratiche. In estrema sintesi, si può notare che il modello del Glass-Steagall Act, rigido ed inflessibile, sia lontano: la regola generale si frammenta in una serie di casistiche, esenzioni, eccezioni che, in un comprensibile empito di proporzionalità, cerca di bilanciare gli interessi in gioco e di destreggiarsi nella complessità delle attività di investimento, spesso caratterizzate da una “ibridazione” delle finalità (speculative congiunte a quelle di copertura) che risulta apparentemente insofferente a divieti astratti dal sapore manicheo.
Ma, dettagli a parte, il messaggio dell’introduzione nell’ordinamento statunitense di una norma che – con i vari limiti soggettivi (solo banche commerciali) e oggettivi (riferiti alle attività di investimento alle stesse vietate, con una disciplina quasi puntiforme su ciò che deve e ciò che non deve rientrare nel divieto) – per la prima volta in un ventennio segna una decisa inversione di tendenza nelle politiche pubbliche di intervento nel settore finanziario è significativo.
Né l’Europa è rimasta a guardare. Innanzitutto, il Regno Unito: Paese che ospita uno dei mercati finanziari più importanti del mondo e in cui duramente la crisi ha fatto sentire la propria morsa. In questo caso, la risposta normativa scaturisce da una proposta formulata da una Commissione indipendente sulle banche, nominata dal Governo britannico e presieduta dall’economista di Oxford John Vickers. E “Vickers Rule” è, anche qui, chiamato volgarmente l’intervento normativo confluito nel Financial Services Act 2013 (in particolare, la parte cd. Banking Reform Act), che introduce, sulla scia di quanto concluso dalla Commissione, riforme strutturali nel mercato bancario. Il metodo potrebbe apparire differente da quello praticato negli Stati Uniti, ma il risultato è analogo. Il Regno Unito ha infatti privilegiato la soluzione di “recintare” (secondo la traduzione appunto della locuzione “Ring-fencing”) l’entità che svolge attività bancaria tradizionale, ovvero l’attività “core” per eccellenza, la raccolta di fondi tra il pubblico. Ed è proprio questa attività “core” che va difesa, nell’ottica del legislatore UK, impedendo a chi è abilitato a svolgerla di porre in essere attività nominativamente individuate come rischiose. Tra queste, spicca nuovamente l’attività di trading per conto proprio; compare inoltre anche il divieto di avere esposizioni nei confronti di alcune financial institution. Se peraltro, a prima vista, la normativa inglese appare anche più restrittiva di quella statunitense, questa conclusione non può accogliersi acriticamente. Non mancano, anche in questo caso, eccezioni ed esclusioni (tra cui quella de minimis, relativa ad intermediari creditizi più piccoli), che ammorbidiscono il rigore del divieto generale. Inoltre, è interessante notare come in generale la legislazione inglese, a differenza di quella britannica, ammetta la coesistenza nello stesso gruppo della banca commerciale e della società di investimento; una regola che però impone apposite regole di governance e prudenziali (oltre che appositi poteri dell’Autorità di vigilanza) per evitare che l’appartenenza al medesimo conglomerato non si traduca in condivisione dei rischi e quindi di contagio della prima entità in caso di crisi della seconda.
Ancora, si può menzionare – ma per brevità non spingersi oltre- il caso della Francia e della Germania. Entrambe, estremamente semplificando, con due leggi nazionali hanno previsto l’impermeabilizzazione delle banche commerciali – che superino certi limiti dimensionali - dai rischi di alcune attività speculative (ancora una volta, in primis, il proprietary trading).
Ma il dibattito si è presto spostato a livello europeo, per due ragioni dirimenti. In primis, una delle linee fondamentali di reazione del vecchio Continente alla crisi che lo ha squassato è stata quello di elevare a livello di istituzioni eurounitarie il maggior numero possibile di responsabilità in tema di regolazione e vigilanza dei mercati bancari e finanziari. Nella temperie che ha portato all’(ancora incompleta) Unione Bancaria, la discussione sulle cause della crisi e sugli strumenti regolamentari e amministrativi per fornirvi rimedio e scongiurarne una ripetizione in futuro non ha potuto allora disinteressarsi del tema delle riforme strutturali. Ancora, sotto un profilo sostanziale, l’adozione di regole penetranti che ex ante disciplinino ciò che una banca può o non può fare, ponendo limiti all’autonomia imprenditoriale della stessa e mettendo in crisi un modello – quello della banca universale – che proprio nell’integrazione europea aveva trovato la propria consacrazione, non poteva sfuggire alle maglie del legislatore sovranazionale. D’altronde, se il Mercato Unico deve essere davvero tale, non sembra possano essere ammesse (o comunque non sembra che possano esserlo in assenza di un vaglio generale delle istituzioni preordinate a garantire il funzionamento di detto mercato) regole che incidono pesantemente sulla possibilità degli intermediari di operare in determinati territori, imponendone modifiche strutturali od organizzative ed ostacolandone l’ampliamento dell’attività in considerazione della necessità di assicurare la compliance a discipline diverse, Stato per Stato. Le ricadute in tema di concorrenza (uno dei pilastri della costruzione europea) sono peraltro evidenti: discipline diverse in senso all’Unione giustificano fenomeni di arbitraggio normativo e tentativi dei singoli Stati di giocare “al ribasso” per attirare attività economiche sul proprio territorio, assoggettandole alla propria tassazione.
Nel 2012 è dunque stato reso noto il cd. Rapporto Liikanen, ovvero il documento conclusivo dell’High Level Group di esperti (presieduto dal Governatore della Banca Centrale di Finlandia, Liikanen, appunto) costituito l’anno precedente dalla Commissione Europea proprio per valutare la necessità di misure strutturali per il mercato bancario europeo. Del documento, peraltro, si consiglia la lettura anche al di là dello specifico interesse per i temi in questione, perché, nella prima parte, concilia sintesi e precisione nell’esame della più grave crisi finanziaria e sociale del nostro tempo[2].
Il Rapporto si produce in una spietata analisi delle problematiche emerse nel settore bancario in occasione della crisi (eccessiva assunzione di rischi incentivata da sussidi infragruppo; aumentate complessità, dimensione e operatività; supervisione inadeguata e eccessiva confidenza nel management e nella market discipline; aumentata interconnessione tra operatori e mercati, rischio sistemico e limiti alla “risolvibilità” delle banche, ecc….), evidenziando le storture e le miopie che, accumulandosi nel tempo, ne hanno amplificato gli effetti in modo dirompente. Per il punto in esame, merita citare quanto affermato a pag. 89, testualmente: “In Europa, il modello di banca universale ha una storia relativamente lunga di combinazione della banca commerciale della banca d'investimento sotto lo stesso tetto. Tuttavia, c’è stata una tendenza prima della crisi tra le più grandi banche europee, di concentrarsi sempre più sull’investment banking, incluse operazioni trading, e di aumentare la propria dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso’’.
Da siffatte premesse, sgorgano coerenti conclusioni, che si articolano in due opzioni da sottoporre al legislatore UE: a) una, più “soft”, suggeriva l’introduzione di un requisito di capitale non ponderato per il rischio, per le attività di investimento e una possibile separazione funzionale delle attività di investimento significative, a seguito di una valutazione di vigilanza sulla sostenibilità del piano di risoluzione e recupero; b) l’altra, più tranchant, prospettava una separazione funzionale immediata delle attività di investimento, eccedenti un certo limite, da quelle bancarie commerciali e retail, senza una previa valutazione di vigilanza (la trading entity e il resto del gruppo avrebbero poi dovuto essere economicamente, legalmente e operativamente indipendenti).
Sulla scorta di queste proposte, la Commissione ha varato, nel 2014, una proposta di Regolamento sulle misure strutturali delle banche (2014/043) mirante dichiaratamente a “prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di entità grandi, complesse e interconnesse del sistema finanziario, in particolare enti creditizi”. Nella sua versione originaria, il Regolamento BSR (Banking Structural Reform) prevedeva un divieto generale di trading per conto proprio e di operare con o tramite fondi di investimento alternativi (FIA) nonché la separazione funzionale di altre attività di negoziazione (tra cui, principalmente, il market-making), qualora, in esito ad uno scrutinio della competente autorità di vigilanza, risultassero superati alcuni parametri fissati dal Regolamento e da una emananda disciplina attuativa. La disciplina avrebbe dovuto riguardare solo entità di dimensione particolarmente rilevante (i cd. enti too big to fail) e, come ormai ci si attenderà, conteneva una serie di esenzioni volte a conformare i divieti all’effettiva rischiosità delle diverse attività, in ossequio al principio di proporzionalità. Anche in questo caso, peraltro, come già in alcune discipline nazionali sopra sinteticamente passate in rassegna, la compresenza nella stessa articolazione di gruppo dell’entità bancaria tradizionale con quella deputata alle attività di investimento era ammessa, ma con una serie di prescrizioni volte a porre un diaframma tra le due, al fine di preservare la prima dalle vicende dell’altra.
Senza indugiare sulle cd. technicalities, quello che rileva sottolineare è che anche l’Unione Europea sembrava avviata verso una rimeditazione del modello di banca universale, di cui veniva paventata la rischiosità o la difficile compatibilità con le finalità di vigilanza, allorchè l’intermediario fosse di grandi dimensioni ed avesse una struttura organizzativa, patrimoniale o finanziaria di particolare complessità. In questo processo, la soluzione ipotizzata era quella di recuperare, sia pure in un formato meno esteso e più aggiornato, alcuni stilemi antecedenti all’adozione del modello di vigilanza prudenziale, che sommariamente si è tratteggiato nella prima parte di questo intervento. In particolare, ci si riferisce all’introduzione di un divieto in astratto ed ex ante di svolgere alcune attività finanziarie non legate a quella bancaria tradizionale da un nesso di strumentalità e che anzi rischiano di accrescerne i rischi e vanificarne funzioni e risultati.
Tuttavia, non è questa la fine della storia. Il Regolamento BSR non è mai stato approvato; e mai lo sarà, per le ragioni che vedremo nella prossima ed ultima parte. In quell’occasione, ci si dovrà anche confrontare con gli opposti spunti che nascono dal dibattito politico nazionale, in cui invece l’adozione di misure strutturali è è di stretta attualità, come dimostra, tra l’altro e da ultimo, il testo del cd. Contratto di governo stipulato dalle due forze politiche che dovrebbero assumere a breve le responsabilità di conduzione del Paese.
(22 maggio 2018)
*Le opinioni espresse non rappresentano né impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza: Banca d’Italia
[1] Per tutto quanto segue, e per ben più approfonditi riferimenti, si rinvia al volume Il tramonto della banca universale? a cura di M. Rispoli Farina e M. Porzio, Napoli, 2017, ed in particolare agli scritti della seconda parte, relativi alle leggi nazionali sulla separazione tra attività bancarie e attività di investimento (di SCALCIONE, LIDDELL, CAPDEVILLE).
[2] Il documento è pubblico e facilmente reperibile su internet.