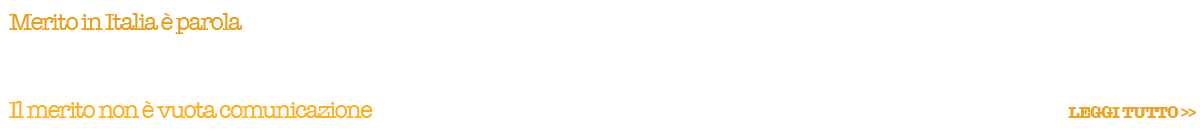Il merito nell’accesso alle professioni: una questione dibattuta
di Alarico Barbagli
“Nessun sia vile e negligente a cui abbella buon pregio seguire. Ché pregio è un miro di clartà gioconda, ove valor s’agenza e si pulisce; e chi sé mira ad esso sé nudrisce di ricche laude, e di gran pregio abonda. Ma non s’à per retaggio né antiquo legnaggio, né si dona di bada o vende o ‘mpegna, né tra malvagi regna, ma in uom cortese, e pro sta per usaggio”. Con queste parole, in pieno Duecento e all’apice della civiltà comunale, il cronista e rimatore fiorentino Dino Compagni introduceva la sua celebre “Canzone del pregio”, vero e proprio manifesto dell’alta virtù alla quale avrebbero dovuto idealmente tendere gli esponenti delle più cospicue categorie sociali del suo tempo, tra le quali l’autore contava anche i professionisti, menzionando infatti espressamente tra i destinatari del componimento i dottori di diritto, i notai, i medici: una virtù che il Compagni chiamava “pregio”, vocabolo mutuato dalla terminologia dei trovatori provenzali ad indicare concetti quali l’”onore”, la “valentìa”, diremmo noi, oggi, il “merito”.
La modernità delle parole del poeta offre il destro per fare il punto, e mettere nero su bianco alcune considerazioni, a margine di un tema assai attuale, spesso abusato, certamente di elevata rilevanza sociale, qual è quello dell’accesso alle professioni intellettuali. È noto come negli anni più recenti la materia sia stata segnata da una serie di interventi normativi che, sebbene si contraddistinguano nel loro complesso per una certa disorganicità, sembrano essere ispirati ad un concetto di “accesso” molto più ampio rispetto al passato, dilatato ad abbracciare, oltre ai meccanismi di ammissione agli ordini professionali quali concorsi ed esami di abilitazione, anche la fase precedente a questi ultimi – si fa riferimento ai tentativi di dare vita a corsi di studio universitari definiti “professionalizzanti”, che nelle intenzioni dovrebbero essere caratterizzati da legami con la pratica professionale più stretti di quanto non lo siano stati sinora quelli intrattenuti con i tradizionali corsi di laurea approntati dagli atenei italiani – e quella successiva – principalmente attraverso l’adozione di provvedimenti normativi dichiaratamente volti a favorire la concorrenza all’interno di quello che, con espressione non certamente felice, viene certe volte indicato come “mercato delle professioni”–. Nelle dichiarazioni dei rispettivi assertori si tratta di interventi normativi che rispondono alla primaria necessità di salvaguardare, appunto, il principio del “merito”, elevato correttamente a regola-guida per disciplinare la materia dell’accesso alle professioni liberali: il problema cruciale che investe l’intera materia consiste nell’individuazione dei tempi e dei modi entro i quali applicare e far valere questo fondamentale criterio. Sul punto si fronteggiano due visioni del problema, sostanzialmente antitetiche sia nei presupposti che, inevitabilmente, nelle soluzioni proposte.
Una prima impostazione, di matrice marcatamente liberista, tende a ricondurre l’intero settore delle libere professioni alla categoria omnicomprensiva delle “attività produttive”, operando un accostamento molto deciso di esse al concetto d’impresa. In quest’ottica, la selezione dei professionisti viene affidata al “mercato” attraverso il meccanismo della “concorrenza”: si ritiene, infatti, che nel medio e lungo periodo il crudo confronto sul campo tra prestatori d’opera intellettuale consentirà l’emersione dei soggetti più virtuosi e competenti, a discapito dei colleghi più inadeguati per preparazione e capacità di aggiornamento professionale dinanzi alle sfide poste quotidianamente da una società complessa e frastagliata come quella contemporanea. Il ragionamento di fondo di chi propugna questa tesi è che il mercato orienterà la “domanda” proveniente dai “consumatori” verso i professionisti più “competitivi” per preparazione e capacità d’innovazione, provocando d’altro lato l’abbandono di tutti gli altri. La sostanziale equazione tra attività professionale e impresa risulta evidente già dal lessico scelto da coloro che sostengono questa visione della materia e segnalato tra virgolette nelle righe che precedono. Si tratta di una lettura del problema che negli ultimi anni ha riscosso un successo notevole in seno alla classe politica italiana, ispirando un’abbondante quantità di proposte d’intervento indirizzate perlopiù ad allargare le maglie dei congegni di accesso alle professioni onde conseguire, in ultima analisi, l’ampliamento della platea dei prestatori d’opera intellettuale e favorire in tal modo il meccanismo della concorrenza: rimontano a questo obiettivo proposte quali la totale abolizione degli ordini professionali e la riuscita abolizione dei minimi tariffari obbligatori, o anche istanze tese a mettere in competizione l’uno con l’altro due o più ordini professionali mediante l’attribuzione di settori di attività, esclusivi dell’uno, anche ad altri di essi o addirittura alle imprese vere e proprie, come è accaduto, ad esempio, nel caso della facoltà di vendita di alcune tipologie di medicinali da parte di parafarmacie e grandi catene di distribuzione e non più soltanto presso le farmacie tradizionali, o dell’autenticazione delle sottoscrizioni negli atti di compravendita di beni mobili registrati quali le autovetture, sino a non molto tempo fa prerogativa del notaio, estese oggi anche a soggetti diversi da quest’ultimo.
Il secondo approccio alla questione è più tradizionale, affonda le proprie radici nelle trame della storia giuridica nazionale e continentale, e prende concettualmente le mosse da una netta distinzione tra professioni liberali e attività d’impresa. La linea di demarcazione tra le due sfere coincide per tutte le professioni con la qualificazione delle rispettive prestazioni come attività complesse a contenuto essenzialmente intellettuale, che presuppongono la padronanza di speciali competenze tecniche di natura eminentemente intellettuale ed un rapporto inevitabilmente fiduciario tra professionista e “assistito” in ragione, appunto, dell’irripetibilità della prestazione stessa in quanto strettamente legata alle specifiche capacità del singolo prestatore d’opera. A questo carattere comune a tutte le professioni si aggiungono ulteriori rivendicazioni circa una più marcata incompatibilità con l’attività imprenditoriale da parte di determinate categorie professionali, talvolta in ragione dello status del tutto peculiare di cui esse godono all’interno dell’ordinamento – come nel caso, ad esempio, dei notai, i quali, sebbene organizzati in forma di ordine professionale, sono titolari dell’esercizio di pubbliche funzioni – oppure altre volte a causa degli interessi e dei diritti che dall’ordinamento stesso sono chiamate a tutelare – quali il diritto alla salute nel caso di medici e farmacisti e il diritto alla giustizia per quanto riguarda gli avvocati – che per la particolare delicatezza ad essi connaturata mal sopportano di essere piegati a logiche di mercato. Un’impostazione di questo tipo rigetta necessariamente l’idea che possa essere il gioco della concorrenza a selezionare i soggetti più meritevoli di esercitare la professione, e insiste piuttosto sulla difesa del sistema di sbarramento preventivo all’accesso mediante il corretto svolgimento della pratica professionale ed i tradizionali esami di abilitazione e concorsi, dei quali perfezionare semmai le regole al fine di garantire l’effettivo successo del criterio del “merito”. Va in questa direzione, ad esempio, la riforma della disciplina dell’esame di abilitazione per la professione di avvocato, la cui entrata in vigore dovrebbe essere imminente, che si caratterizza per un inasprimento delle regole concernenti sia le prove scritte, con il passaggio dalla possibilità di consultazione da parte dei candidati, in sede di esame, di codici annotati con la giurisprudenza a codici contenenti la sola nuda norma di legge, sia le prove orali, laddove viene reso obbligatorio sostenere l’esame su discipline quali diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale. Può essere ricondotta a questo indirizzo anche l’introduzione del sistema delle specializzazioni forensi, al momento in fase di avvio, ispirato in un certo qual modo al collaudato modello delle specialità mediche con l’obiettivo di affinare la preparazione tecnica della classe forense mediante la canalizzazione e qualificazione dei propri affiliati su specifici settori giuridici, da conseguire attraverso percorsi misti di formazione continua e comprovato svolgimento dell’attività professionale.
Il conflitto tra i due modelli di professione è evidente. Ad un primo sistema caratterizzato da una valutazione ex post del merito ad esercitare l’attività di prestazione d’opera intellettuale e dal progressivo avvicinamento tra le nozioni di professione e impresa, se ne contrappone un secondo che si riconosce nella cernita ex ante dei soggetti considerati meritevoli di accedere agli ordini professionali e nella cristallina alterità tra le due sfere, professionale e imprenditoriale. Dopo un certo numero di anni durante i quali si è assistito a numerosi e talvolta tangibili tentativi di applicazione del primo di questi due modelli al mondo delle professioni è tuttavia possibile tirare alcune conclusioni circa lo status quo della materia. Le proposte di riforma che si sono tradotte in interventi effettivi hanno mostrato segni inequivocabili di criticità. L’abrogazione del sistema dei minimi tariffari imposti normativamente, lungi dal garantire, come era invece nelle intenzioni, l’apertura del “mercato” ai giovani professionisti, provocando un generale abbattimento dell’entità dei compensi ha danneggiato soprattutto questi ultimi: il fenomeno è particolarmente avvertito all’interno della classe forense, tanto che è allo studio l’introduzione di forme di “giusto compenso” per il legale almeno nei casi in cui questi si trovi a prestare la propria opera in favore di assistiti particolarmente “forti”. Se, poi, effettivamente nel medio-lungo periodo il criterio valutativo “in corso d’opera” delle competenze del libero professionista potrebbe portare all’emersione dei soggetti più qualificati, non può tuttavia tacersi dei dubbi circa l’effettivo giovamento che i singoli assistiti, nonché l’ordinamento stesso, trarrebbero in termini di “certezza” – si pensi alla possibile impennata del contenzioso giudiziale – dall’affidamento di competenze così delicate a una platea talmente ampia da comprendere, almeno nel breve periodo, anche soggetti privi di un’opportuna preparazione tecnica e, quindi, potenzialmente dannosi. D’altra parte, è opportuno segnalare il rischio che la tendenza opposta sfoci nella ricerca di un ipertecnicismo a tutti i costi che passi, ad esempio, attraverso il paventato ridimensionamento degli insegnamenti umanistici nei piani di studio dei corsi di laurea italiani – si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’importanza del diritto romano per la formazione del giurista – e che, privando il professionista della necessaria visione d’insieme della propria disciplina, ne mortifichi l’essenziale carattere “intellettuale”. Il dibattito intorno al “merito”, anzi, al “pregio”, rimane dunque aperto.
29 settembre 2016